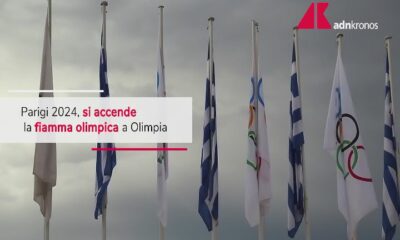Ultima ora
Sostenibilità, Urso: “Europa si muova per far...
Sostenibilità, Urso: “Europa si muova per far crescere filiera tecnologica green”
Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenuti alla presentazione all'Adnkronos del Secondo Rapporto Annuale dell’EsgCultureLAB

La prossima trilaterale con Italia, Francia e Germania "si svolgerà nella seconda metà di gennaio a Parigi sulla tecnologia Green perché siamo convinti che su questa tecnologia è necessario che l’Europa si muova affinché ci sia la possibilità di far crescere una filiera della tecnologia Green a cominciare dai pannelli fotovoltaici in Europa, per evitare di installare anche in Italia nei prossimi anni esclusivamente pannelli cinesi". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo alla presentazione all'Adnkronos del Secondo Rapporto Annuale dell’EsgCultureLAB
Su questo tema, ha detto "lunedì c’è un vertice in video conferenza con il commissario Breton" e gli altri paesi "perché siamo convinti - ha spiegato Urso - che bisogna coniugare la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica alla sostenibilità sociale e produttiva del sistema europeo". A tale proposito Urso ha ricordato come "non a caso siamo riusciti a modificare alcuni dossier importanti che erano in corso d’opera e direi pregiudicati da una visione ideologica : quello che riguarda l’euro7 dove abbiamo garantito la salvaguardia del motore endotermico nei prossimi anni e quello che riguarda il packaging dove abbiamo garantito l’economia circolare italiana cioè quella del riciclo, fondamentale per quanto riguarda la nostra industria e anche per la sostenibilità ambientale del nostro paese".
Ultima ora
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi

Nessun '6' né '5+', jackpot sale a 91,3 milioni

Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione del Superenalotto di oggi, 16 aprile 2024. Il concorso di oggi è il primo della settimana. Si torna a giocare tra 2 giorni, giovedì 18 aprile, per la seconda estrazione.
Il prezzo di una schedina
La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.
La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.
Quali punteggi vincono?
Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:
- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;
- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;
- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;
- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;
- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.
Ho vinto o no?
E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.
La combinazione vincente di oggi
Ecco la combinazione vincente: 1 - 3 - 11 - 53 - 75 - 81. Numero Jolly: 61. Numero Superstar: 26. Centrati invece dieci '5' da oltre 18mila euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 91,3 milioni.
Economia
Ponte Messina, ministero delle Infrastrutture:...

L'annuncio dopo le richieste avanzate dal ministro dell'Ambiente. Opposizione all'attacco: "Oltre 200 rilievi, progetto dannoso, inutile, costoso e pieno di incertezze"

"Le integrazioni al progetto del Ponte sullo Stretto, richieste in sede di conferenza di servizi, saranno fornite entro 30 giorni". Lo annuncia il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato da Matteo Salvini. "Si tratta della normale procedura ed è corretto approfondire tutti gli aspetti di un’opera che sarà unica al mondo", sottolinea il Mit.
La richiesta del ministro dell'Ambiente
"Nella giornata di lunedì 15 aprile, entro il termine stabilito dalla legge, la Commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato e trasmesso alla società Ponte sullo Stretto di Messina spa la richiesta di integrazioni sulla istanza presentata da quest'ultima lo scorso 26 febbraio", ha reso noto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.
"Con questa istanza - aggiunge il ministro - si è dato avvio, ai fini del relativo aggiornamento e completamento, alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all’opera. Il procedimento avviato con l’istanza del 26 febbraio scorso si connette, per un verso, a quello iniziato nel 2011 e, per altro verso, alla nota che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Commissione Ue in data 8.11.2023, con alcuni chiarimenti riguardo alla Via e alla Vinca. Nella definizione del testo della richiesta di integrazione, che è atto tipico della prima parte di ogni procedimento di valutazione di impatto ambientale, si è tenuto conto, come di consueto, anche di elementi tratti dai contributi di Ispra e di soggetti non pubblici aventi diritto, per legge, ad esprimersi”, conclude.
"Oltre 200 rilievi dal ministero, anche Pichetto è nemico dell'Italia?"
Sulla richiesta di chiarimenti avanzata dal ministero dell'Ambiente l'opposizione va all'attacco. "Apprendiamo che il ministero dell’Ambiente ha letto i documenti sul progetto definitivo del Ponte di Messina di Salvini e ha fatto più di 200 rilievi denunciando la carenza di documenti essenziali. Quando lo abbiamo denunciato noi, con un esposto e in Parlamento, il ministro Salvini ci ha accusato di essere nemici dell’Italia, ci chiediamo se a questo punto lo sia anche il suo collega ministro Pichetto Fratin", afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Evidentemente anche il ministero dell’Ambiente conferma ciò che da mesi non solo il Pd, ma le associazioni, il territorio, dicono: siamo di fronte a un progetto dannoso, inutile, costoso e pieno di incertezze, su cui gli esperti sollevano enormi criticità".
"Salvini e Meloni basta spot"
Di un "macigno" che arriva "sul progetto del Ponte sullo Stretto, con più di 200 richieste di integrazione da parte del Ministero dell'Ambiente, che corrispondono a altrettante lacune" è anche il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. "È la conferma - attacca - di quanto avevamo preannunciato ieri a Messina, dove ho incontrato rappresentanti di associazioni e cittadini che si oppongono al progetto. Ho esposto la nostra posizione: il nostro non è un no 'ideologico'. È il no di chi non può accettare che un Governo nazionale, di fronte alle gravi carenze infrastrutturali della Sicilia e della Calabria, risponda con uno slogan propagandistico, con un progetto vecchio, risalente al 2011/2012, pieno di falle sul piano ingegneristico, ambientale, trasportistico e finanziario. Presidente Meloni, ministro Salvini - dice poi Conte rivolgendosi direttamente ai vertici del governo- : basta con gli spot elettorali. Meno promesse e più serietà nell’affrontare i problemi veri dell’Italia".
Ultima ora
Scontri alla Sapienza, studenti assaltano Commissariato:...

Danneggiate due volanti di vigilanza all'ateneo

Scontri all'università La Sapienza di Roma. Erano circa 300 gli studenti pro-Palestina dei Collettivi che nel pomeriggio di oggi hanno manifestato all'interno dell'ateneo, provando ad assaltare prima il Rettorato, poi il Commissariato (FOTOGALLERY). I primi momenti di tensione quando alcuni di loro hanno tentato di fare irruzione all'interno del Rettorato, dove erano riuniti in seduta congiunta Senato accademico e consiglio d'amministrazione dell'Università per l'approvazione di un documento che rifiuta "il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale". L'irruzione è stata contenuta e respinta dalla polizia. A quel punto i manifestanti hanno dato vita a un corteo spontaneo all'interno della città universitaria, durante il quale uno degli studenti è saltato su una volante, danneggiandola. Lo studente è stato così fermato dagli agenti e portato in commissariato. Il nutrito gruppo di manifestanti ha quindi assaltato i locali del Commissariato presso l'Università. Durante il tentativo di irruzione uno di loro ha aggredito il dirigente di polizia a calci e pugni, procurandogli ferite. Anche questo manifestante è stato bloccato e trattenuto dalla polizia.
I manifestanti, convinti che i due fermati fossero all'interno del Commissariato dell'università, hanno tentato più volte di fare irruzione. Successivamente invece hanno raggiunto il vicino Commissariato San Lorenzo, dove tuttora stazionano.
Durante gli scontri i manifestanti hanno pesantemente danneggiato due auto della vigilanza in servizio alla Sapienza.